La mia recensione al volume che è stato presentato il 1 luglio alla Libreria Coop Ambasciatori di Bologna, come sesto incontro de “Il cinema ritrovato all’Ambasciatori – 8 libri di Cinema sotto le Stelle”.
“Per me la posterità è volgare come il successo. Non mi fido della posterità. Il bello non viene necessariamente riconosciuto a distanza di tempo.”
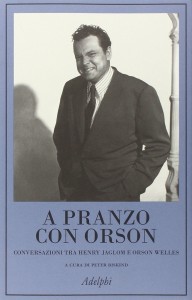 Negli ultimi anni della sua vita, tra il 1983 e il 1985 Orson Welles pranzò quasi ogni settimana al ristorante “Ma Maison” di West Hollywood con il più giovane regista Henry Jagtorn, il quale con il permesso dell’amico registrò le conversazioni. Oggi, con l’aiuto di Peter Biskind, Jagtorn ha deciso di rendere pubblica in questo volume una parte di queste conversazioni.
Negli ultimi anni della sua vita, tra il 1983 e il 1985 Orson Welles pranzò quasi ogni settimana al ristorante “Ma Maison” di West Hollywood con il più giovane regista Henry Jagtorn, il quale con il permesso dell’amico registrò le conversazioni. Oggi, con l’aiuto di Peter Biskind, Jagtorn ha deciso di rendere pubblica in questo volume una parte di queste conversazioni.
Contrariamente a quanto si verifica in Le Cinéma selon Hitchcock di Truffaut o Conversations with Wilder di Cameron Crowe, è immediatamente evidente che queste non sono interviste, e che il regista non ama parlare dei suoi film – solo alcune interessantissime pagine dedicate a F for Fake costituiscono un’eccezione. Sono conversazioni tra due amici di diversa età ed esperienza, “senza filtro”, che la natura affabulatrice, politicamente scorretta, larger than life e quasi rabelaisiana di Welles arricchisce di ricordi, riferimenti, aneddoti (non necessariamente veritieri) e giudizi fulminanti.
Scopriamo che non sopportava Katherine Hepburn e Spencer Tracy (e più in generale gli irlandesi, con l’eccezione di John Ford), che Bogart era un attore di seconda categoria ma simpatico e un vero divo, come pure Clark Gable che era un “simpatico furbacchione”; che Greta Garbo snobbò Marlene Dietrich e che Carole Lombard era sboccata come la cameriera di una bettola ma molto più intelligente dei suoi registi. Welles ha parole di fuoco per Louis B. Mayer, Irving Thalberg e David O. Selznick la cui missione era quella di “cancellare la cifra del regista”; difende Erich Von Stroheim e Howard Hawks e considera invece Hitchcock “pigro e megalomane”; e se trova Chaplin – per cui scrisse Monsieur Verdoux – “assolutamente un genio”, lo considera anche “un cretino” mai disposto a riconoscere il contributo altrui, e gli preferisce Harold Lloyd per la maggior inventiva e soprattutto Buster Keaton, che con Come vinsi la guerra ha realizzato “forse il più grande film in assoluto. Il più poetico che abbia mai visto”.
Ma al di là dell’aneddotica, quello che emerge dal testo è il ritratto di una personalità complessa e densa di contraddizioni – bellicosa ma vulnerabile, cospiratrice ma impulsiva, timida ma desiderosa di mettersi in mostra, generosa ma capace di serbare rancore, in grado di inferocirsi e poco dopo ridere a crepapelle – ma anche piena di vita, di interessi, occasionalmente in preda alla depressione ma anche ancora capace di entusiasmarsi per una nuova idea o un nuovo progetto, che sia un film, una sceneggiatura o un libro. Un Grande a pieno titolo, una di quelle figure che cambiano il proprio destino, quello delle persone che li incontrano, e dell’arte alla quale cui si dedicano.
